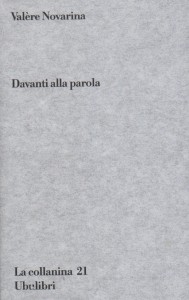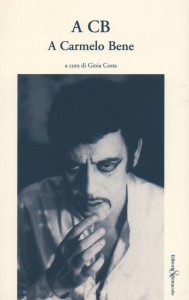A passeggio nella foresta delle lingue
Valère Novarina genera sorpresa ad ogni lettura: il suo ultimo testo, La Scène, è magia della parola, passione del ritmo e logica della composizione.
Ogni volta che Novarina compone un testo teatrale opera in una struttura rigida: nei vari taccuini, appunti, lettere e pamphlet ha raccontato la sua pratica di attaccare il testo al muro e passeggiarci dentro. Durante la traduzione italiana di L’animale del tempo lo abbiamo fatto insieme, ed ho visto come per incanto il flusso di parole ordinarsi nella struttura.
In quell’occasione dovevamo fare dei tagli e scegliere fra due diverse versioni sceniche del Discours aux animaux la partitura per Roberto Herlitzka. Attaccato il testo al muro in caratteri piccoli, come un lungo rotolo di parole, periodi e grafemi, Novarina con una matita ha decomposto per me le zone del testo. Il point d’orgue dell’inizio, il diario, l’avvenimento del métro, la lettera al padre, il sogno, la lista litanica. Come pietre di un antico muro a secco, i pezzi tenevano seguendo un ordine di equilibri e forze. Anche in questo testo appaiono frasi realmente ascoltate, citazioni di latino ecclesiastico, follie televisive fatte dissolvere in una grammatica impazzita, memorie di Leonardo da Vinci, alterazioni dei poeti a lui cari o di cantilene infantili e filastrocche.
Durante il nostro incontro di revisione, abitudine presa fin dal primo libro nel 1989, Novarina tirava fuori dagli scaffali del suo atelier miniere di argot, gemme d’etimologia, antichi fedeli dizionari che custodiscono le origini dei vocaboli. Così, ogni dubbio diventava l’occasione di una scoperta, generando il piacere di soffermarsi su una radice o sulla storia, sempre lunga e misteriosa, di una parola, accompagnandola attraverso i casi che ne hanno trasformato il senso fino ad oggi. Uno dei tanti begli esempi è stato quello dello chandail, il maglione di trecce bianche. È in realtà una memoria dei mercanti d’aglio, i marchands d’ail, che arrivavano dalle campagne con le loro trecce da vendere attorno al collo. Per rivedere La Scène, che segna un momento importante nella scrittura di Novarina riportandolo a una purezza linguistica e ad una intransigenza di ricerca degne della più alta tradizione francese, abbiamo passato alcuni giorni fra Parigi e la Normandia, leggendo riga per riga, insieme e ad alta voce, l’intero libro. Di questi giorni dobbiamo ringraziare la tenace passione di Jacques Le Ny, che dal suo Atelier de la Traduction tesse incontri fra le lingue in omaggio alla parola. Ciò che è curioso è che, affidato il testo al suo editore P.O.L., Novarina ne elabora ogni volta una versione per la scena. Tagli a parte, le differenze fra l’uno e l’altra sono minime: leggere inversioni, cambi di cifre nelle enumerazioni, spostamenti dell’ordine dei nomi negli elenchi. Prova che lui davvero scrive con le orecchie, come dichiarava in apertura della sua Lettera agli attori. In effetti, per tradurre la sua lingua, terminata la verifica dell’esattezza dei termini, bisogna immergersi nel suono, nella scansione della pagina, nel movimento fra le parole che tesse quel richiamo sonoro che è il vero protagonista del suo teatro.
Le lunghe sessioni di revisione sono per lui motivo di una “lezione di italiano”, che dice di studiare dal 1989. E il suo piacere di immergersi in più dizionari, antichi testi, vocabolari ed enciclopedie diventa in realtà una privilegiata occasione di scoprire il francese più segreto e le sue intime motivazioni.
Hystrio, anno XVII, n 3 – 2004
Questo libro ha alle spalle una storia iniziata nel 1989 ad Avignone. In quella occasione, il Festival ospitava tre spettacoli di Valère Novarina e presentava l’intera sua opera, integralmente ripubblicata da POL. La scoperta del ritmo della scrittura, della forza vitale contenuta nelle invettive, negli sdegni, nelle esortazioni all’attore, le idee che guidavano le scelte artistiche e lo sguardo che Novarina rivolgeva a quel mistero rappresentato dal corpo dell’attore sono stati l’origine di un incontro dal quale sono nate cinque traduzioni, ma anche l’occasione di un lungo viaggio fra il francese e l’italiano, che ha fatto affiorare le strutture insostituibili di ciascuna lingua e le loro distanze feconde quanto definitive, quelle che nessuna traduzione potrà mai colmare.
La riflessione sulla traduzione interroga il cuore della propria lingua, rivelandone le ossature, le fragilità, le varianti. Ma anche mettendone in luce le unicità e le insufficienze: ogni parola descrive, ben oltre il suo significato, un contesto, che è culturale ma anche emotivo. Ed ogni lingua ha alle spalle una terra e un popolo in continua evoluzione. Così, appaiono le parole univoche o quelle dai mille riflessi. Ed ogni traduzione cerca di restituire non solo il senso – del quale è lecito chiedersi se sia realmente il vero soggetto dell’opera – ma anche l’universo affettivo della lingua d’origine.
L’Animale del tempo è nato dopo più di dieci anni di felice lavoro con Valère Novarina, dopo letture, convegni, incontri e un rapporto che si è arricchito di scoperte condivise e di confidenti esplorazioni. Quando, in occasione della presentazione di Davanti alla parola pubblicato da Ubulibri, Roberto Herlitzka ha letto al Teatro Valle di Roma alcuni brani dei testi fino ad allora tradotti, l’incontro fra la sua sapienza della scena e la ricerca di Novarina ha dato a tutti noi desiderio di continuare. Così, nell’estate del 2001, ha preso forma l’idea di creare uno spettacolo per Roberto Herlitzka dall’Animale del tempo, del quale Valère Novarina avrebbe curato la regia ed io la traduzione e l’adattamento.
La sua realizzazione è stata pensata insieme a Jacques Le Ny che, dal suo Atelier Européen de la Traduction di Orléans, rende possibile la sovrapposizione di lingue e stili, tracciando un secondo percorso che procede parallelo a quello della creazione.
Così, nel giugno del 2002, Roberto Herlitzka ha letto per la prima volta il testo definitivo in italiano: un piccolo registratore fissava il suo incontro con le parole, e il modo in cui egli ha saputo cogliere il senso della corrente ritmica di Novarina ha spinto lo spaesamento insito nel testo verso la creazione di una nuova forma. In seguito, durante l’estate, con Novarina abbiamo ancora rivisto ed affinato la traduzione, scegliendo e controllando ciascun passaggio. Abbiamo ascoltato la risonanza di ogni parola nel teatro dei teatri, il magnifico teatro di Epidauro nel quale la voce prende corpo, e scorre da una scalinata all’altra senza perdere mai tono, assumendo anzi sostanza nella qualità del suono. Fondamentale, infine, è stato il contributo di Ferruccio Marotti nell’assicurare la realizzazione dello spettacolo e la pubblicazione del testo. Il direttore del Centro Teatro Ateneo e Jacques le Ny hanno creato insieme le condizioni affinché Novarina ed Herlitzka potessero lavorare nello spazio e sul testo, superando i mille impegni, le date mai precise, le difficoltà dei luoghi.
Con L’Animale del tempo, che è la prima versione per la scena del Discours aux animaux, abbiamo pensato di ripubblicare qui due testi: la Lettera agli attori e Per Louis de Funès. La Lettera agli attori, scritta in una notte durante le prove della prima messa in scena dell’Atelier volant nel 1968, è la glorificazione del corpo dell’attore e del potere generativo del linguaggio, inteso come soffio vitale e come respiro della scena. Per Louis de Funès è stato scritto invece quando André Marcon provava L’Animale del tempo ed è un omaggio all’attore e al suo funambolico gioco con la luce e con la morte. Sono due testi dedicati all’attore che ritrovano adesso, alla vigilia di una nuova creazione e di un nuovo viaggio fra le lingue e nella parola, la loro forza originaria e la loro naturale collocazione.
Nella scrittura di Valère Novarina dall’ascolto e dalla visione nasce una nuova forma di scrittura, fatta di suono, di spazio, di colore, di movimento. La voce di Oum Kalsoum, gli affreschi di Paolo Uccello a Firenze, le canzoni russe di Bielka, o di un muezzin a Istanbul, ma anche la scoperta della “macchina attoriale” nell’ultimo Pinocchio di Carmelo Bene a Roma o della scomposizione del gesto in Totò hanno preso corpo in Novarina. Intuizioni formali, consonanze impreviste e segrete fratellanze fra le arti hanno dato vita a un aleph che rivela tutte le forme nello stesso momento. I suoi titoli contengono la stessa improvvisa apertura: la lumière nuit è una luce che nuoce o notturna?, devant la parole è una parola che si deve a qualcuno o di fronte alla quale ci si trova? demeure fragile è una fragile dimora o l’esortazione a persistere nella fragilità?
Valère Novarina porta in scena lo spettacolo della lingua. Ma è interessante notare come nelle pagine critiche – ad esempio quando descrive “Il Cristo morto” di Mantegna o il ponte del teatro Nô che separa l’attore dal pubblico –, si abbandoni al suo sguardo visionario. La lucidità della sua scrittura artistica cede il passo a slanci, impeti e dolcezze impreviste solo nella scrittura critica. È l’arte quindi ad essere soggetta alle restrizioni e ai controlli più attenti, e nei testi teatrali Novarina non pare permettersi quelle libertà, quegli involi e quei giochi che nelle pagine critiche rivelano in modo imprevisto la ricchezza e la passione del suo sguardo.
Presentazione per l’edizione italiana di L’Animal du temps di Valère Novarina, L’animale del tempo, Bulzoni, Roma 2003.
Con il concorso dell’Atelier Européen de la Traduction – Scène Nationale d’Orléans
Le peintre, c’est celui qui ne peut se servir des mots.
Sa seule issue, c’est d’être un visionnaire.
Bram van Velde
Devant la parole è una visione, uno scavo oltre l’immagine, una ricerca dell’ossatura profonda, di ciò che sostiene l’apparizione di ogni forma. Quattro sono i capitoli di questo libro: Devant la parole, L’Opérette reversible, Le débat avec l’espace e Demeure fragile, quattro sguardi sulle pratiche dell’arte. Devant la parole è una interrogazione, che torna da un libro all’altro, sull’aura contenuta nella parola umana, che è la nostra carne e il sangue che scorre nelle nostre vene. L’Opérette reversible è una scaglia gettata nella forma dell’operetta: l’intera costruzione vacilla e ne esce una struttura acuminata, destinata a rompersi per ricominciare all’infinito; un teatro che non accoglie nulla di umano. Nel Débat avec l’espace Novarina descrive la nascita della scrittura: per semina, germinazione, maturazione, il libro esce dalla neve come la primavera e da quattro briciole cadute dal libro precedente e raccolte sboccia rigogliosa la vegetazione del libro successivo. Demeure fragile è dedicato alla fragilità dell’attore, con alcune straordinarie pagine sul teatro Nô, ma anche alla fragilità della tela: sotto lo sguardo di Novarina i quadri assumono altre forme e rivelano segnali segreti.
Quando, nella Pinacoteca di Brera, Valère Novarina guarda due quadri – la Madonna con il Bambino di Piero della Francesca e il Cristo morto di Mantegna – in realtà vede somiglianze con pittori lontani nel tempo e nello spazio, linee mai tracciate, forme che si disegnano dal nulla nell’equilibrio dei volumi. Nella Madonna con il Bambino appaiono ai suoi occhi croci invisibili e il misterioso uovo che pende dalla conchiglia diventa un filo a piombo. Allora la natività si trasforma in una deposizione dalla croce, il corallo di sangue al collo del bambino è una preveggenza, e il bambino stesso diventa pane, offerto, al centro dello spazio. Suggerisce di inginocchiarsi, Novarina, nella sala della Pinacoteca che ospita il Cristo morto di Mantegna, per farsi assalire dallo spazio ed entrare così nella vertiginosa prospettiva del quadro.
Accogliendo questa scrittura straripante, indomita, che non cerca consensi e che non offre rifugi, si arriva alla creazione di un nuovo genere. Valère Novarina costruisce tutti i suoi testi attorno a una lingua originante: rifiuta ogni forma di comunicazione che faccia scorrere senso e versi umori e valori ovunque, senza decenza. Nei testi teatrali costruisce una scena popolata di suoni, destinata a straordinari attori pronti ad assorbire le onde di una pagina che deve spezzarsi di continuo: le canzoni si rompono, i monologhi sono interminabili, le scene si susseguono per ricominciare contro ogni regola.
Tre modalità compositive ricorrono nella sua scrittura: la nominazione, la numerazione e la ripetizione. Tre formule dalle quali né la pagina, né tantomeno la scena teatrale escono indenni.
La nominazione chiama in vita immagini, figure e voci. Nominando, la pagina e la scena si popolano di personaggi orali che si autogenerano, fino a sovraffollare di suoni lo spazio destinato all’azione. Numerando, Novarina abbandona la psicologia: elenca, conta, classifica, suddivide, distingue, ordina. Fa sì che la parola trovi il suo posto nello spazio. Infine, la ripetizione, base di ogni ogni formula magica. Tramite la ripetizione, l’ascolto si lascia condurre fino all’ipnosi, in zone di abbandono e di non difesa, di sonnolenza vigile.
Valère Novarina ha liberato la lingua dalla scrittura, legandosi così a una forma altrettanto potente, che è la straripante creazione di suono. In pagina e in scena appaiono, attraverso assonanze, richiami, paronomasie e imprevedibili incontri, un fiume di nomi, nel cui alveo si riversano tutti gli affluenti di tutte le acque del mondo, creando un mare di torrenti, rivoli e ruscelli che scorrono insieme, l’uno sull’altro, accavallandosi fino all’abbandono ritmico, alla spossatezza dell’ascolto, alla rinuncia al senso.
La rinuncia al senso è un elemento centrale, per capire la sua scrittura: è da qui che nascono i testi senza personaggi, gli spettacoli senza atti e scene, i libri senza trama. Rendendo impossibile ogni forma di immedesimazione e di psicologia, ma anche ogni ingerenza dell’umano, Valère Novarina mette al riparo il suo teatro dalle scorie delle parole vuote. Si interroga sul mistero chiuso nell’attore, gelosamente saputo e custodito dal corpo ma mai detto, mai enunciato: “Un giorno bisognerà che un attore affidi il suo corpo vivo alla medicina, che lo si apra, che si sappia infine cosa accade dentro, quando recita. Che si sappia come è fatto, l’altro corpo. Perché l’attore recita con un corpo altro. Con un corpo che funziona nell’altro senso” . Nel suo teatro di parole che non vuole comunicare nulla, gli attori devono uscire ancora di piú dal loro corpo. Sono macchine del sentimento e cancellano ogni residuo legame con il mondo così com’è, con il suo ordine di spazio e di tempo, per poter versare in scena il delirio ritmico da cui l’autore è ciclicamente sommerso.
Scegliendo le strade più inconsuete, i raccordi più ardui e meno visibili, i collegamenti più antichi, in Devant la parole la Bibbia si apre alla cabala, Umm Kahsam e Bach si incontrano sotto le stesse volute, gli stessi cerchi respiratori, Madame Guyon senza averlo mai visto commenta, due secoli dopo, la Madonna con il Bambino di Piero della Francesca, Augustin Lesage dipinge l’avventura spaziale nella sua Peinture n 1 che è a Losanna, e che ha il suo doppio a Villeneuve-lès-Avignon nell’Incoronazione della vergine di Enguerrand Quarton: broccati, stoffe, velluti, pieghe che somigliano ad ali di farfalle, diventano i possibili richiami da un secolo all’altro, da una lingua viva a un’altra ancor piú viva che segretamente, dalla tela di un’immagine esposta a Brera o a Losanna, arriva a dar nuova luce e nuovi ritmi agli affreschi sonori che nascono dalle sue parole. Ciò che le parole esplorano, che Novarina chiede e che noi riceviamo dal loro comune viaggio rinasce in antiche forme che si fondono nelle lingue, nei secoli e negli spazi in queste pagine nelle quali si annega con stordimento e passione.
Prefazione per l’edizione italiana di Devant la parole, Davanti alla parola, Ubulibri, Milano 2002
Con il concorso dell’Atelier Européen de la Traduction – Scène Nationale d’Orléans.
Lampi d’orale
Valère Novarina tende ad annullare qualsiasi senso apparente della lingua per rendere alla parola la sua capacità di evocazione, che diviene una possibile rigenerazione del senso. Altera le terminali ma non tocca mai la radice delle parole, innesta echi di lingue desuete, mescola generi, cambia prefissi e suffissi. Dà vita ad una pagina di suoni. E così ogni termine, nell’onda sonora che genera nella pagina e che viene accentuata dalla propria originarietà, assume pieno valore nel riverbero di senso e di suono che crea attorno a sé quando incontra altri termini.
Nell’Atelier volante la proliferazione verbale e la follia linguistica di alcuni dei nove personaggi non hanno solo la funzione di una rottura con schemi e logiche accreditate nella prassi teatrale: costituiscono in realtà un secondo livello di ascolto e di lettura, offrono una lingua che si dà nella sua nudità, nel suo essere puro suono, una lingua che non vuole sottostare alle regole della sintassi. E questa libertà genera nuove parole, accordi, nuovi e inattesi incontri fra suono e senso.
D’altronde bisogna pur saper custodire un po’ di senso, per poter poi perderlo.
La storia di Boucot, imprenditore onnivoro che strangola la sua impresa nel desiderio incontrollabile di aumentare all’infinito la produzione e quindi il rendimento, accompagnato da Madame Bouche, figura ossessionata dal denaro, che trasforma ogni prodotto degli impiegati in merce da rivendere loro in qualsiasi momento di svago, e dal Dottore, allegoria di colui che esercita il controllo ma anche spalla fedele dei multiformi appetiti dei padroni, sono un pretesto per mettere in scena il meccanismo impazzito del mondo contemporaneo.
Boucot manipola la sintassi e, con questa, governa. Mentre Madame Bouche, regina del mercato, regna. Infatti lei non è ossessionata dal Senso e cambia continuamente registro: moglie devota, poi creatura maliziosa, poi donna capo, Madame Bouche adotta l’atteggiamento che più conviene alle diverse circostanze, affermando sovranamente la sua indifferenza al Simbolico di cui, invece, Boucot non può fare a meno.
I tre sono padroni della lingua e manipolano gli impiegati confondendo loro le idee con formule e spiegazioni prive di senso, ma tanto complesse da sembrare inoppugnabili. Mentre i sei impiegati alfabetici, ebbri di limitazioni, covano imprecisi istinti ribelli perdendosi poi nei luoghi comuni prefabbricati per confonderli. La bellezza di un paesaggio da cartolina, il sogno di un amore impossibile, la speranza di un’intera giornata libera fra trenta anni. Perduta la capacità di articolare in un universo di frasi fatte, gli impiegati perdono in realtà la volontà che, sola, potrebbe permettere loro di fare il salto e, per una volta, di scegliere.
Durante il primo allestimento dell’Atelier volante diretto da Jean-Pierre Sarrazac, nel 1974, in disaccordo con il regista Novarina ha scritto in una notte La lettera agli attori. Questo testo è un documento dedicato allo status odierno del teatro e alla supremazia accordata alla regia nei confronti del copione e di chi recita. Compito del regista è cancellare ogni singolarità, ‘mettere in bella’ corpi e voci, attenuare le differenze uniformando lo spettacolo allo stile dell’unico corpo che non si espone, che non varca le quinte, quello del regista, appunto. Ecco che si ripropone il conflitto fra padroni e impiegati, ovvero il conflitto fra personaggi, che nella lettera viene esteso al conflitto fra il regista e gli interpreti, trasformandosi in competizione per il possesso del corpo dell’attore e della lingua. “Fare parole di teatro vuol dire preparare la pista dove la cosa ballerà, mettere ostacoli, siepi sulla pista di cenere, ben sapendo che solo i ballerini, i saltatori, gli attori, sono belli…”, scrive Novarina, e ricorda loro che “l’attore non esegue ma si esegue, non interpreta ma si penetra, non ragiona ma fa risuonare il suo corpo. Non costruisce il suo personaggio ma decompone il corpo civile e in ordine, si suicida. Non composizione del personaggio, ma scomposizione della persona, scomposizione dell’uomo: ecco cosa si fa in scena”.
Siamo di fronte a un teatro che si presenta come eccesso teatrale nella scrittura, nel quale la parola assume su di sé la tragedia dell’esistenza e della sua crudeltà, nel senso indicato da Antonin Artaud: ogni essere, per nascere e venire al mondo, deve sopprimerne un altro, deve cercare di soddisfare il suo appetito vitale mangiando la vita di un altro.
Non è un caso che la ricorrenza del verbo mangiare sia presente in tutti i testi di Novarina. Mangiare è l’atto estremo dell’affermazione della volontà di vita e in questa accezione rivela la propria derivazione da Artaud: divorare la vita mentre si è divorati da essa. Il “dramma della vita” consiste nell’alternanza di pieno e vuoto e nella tragedia della divisione degli esseri. I personaggi, che diverranno nei testi successivi nomi parlanti, apparizioni orali di figure dette, sono lo specchio dell’impossibile singolarità dell’individuo. Infatti la condanna della modernità risiede proprio nell’accordo indiscriminato, nell’aderenza a regole e stili messi a punto per annullare ogni possibile devianza. Ed è proprio la conformità ad aver generato l’aberrazione, conformità che Antonin Artaud ha denunciato nel desiderio di ammalare e sanare attraverso la prova del dolore estremo, e che Novarina ha messo in evidenza tramite l’attribuzione di un senso altro, la possibile lettura sonoramente e sovranamente estranea a regole e codici.
Ma L’atelier volante è anche l’incarnazione di un’immagine che accompagna Novarina fin dalle origini: quello dell’attore-tubo, corpo forato alle due estremità percorso nel suo interno dalla parola. Una parola che genera la vita attribuendo nomi, che feconda con l’atto stesso di emettere suoni. E l’attore, corpo cavo per eccellenza, è colui che, accogliendo nel proprio corpo ciò che l’autore ha tracciato per lui sulla carta, trasforma in materia e in soffio orale la scrittura che aera le sue cavità.
Come ha messo in luce Maurizio Grande, della cui passione ed acutezza molti di noi sentono la mancanza, “Novarina condensa e riespone la sua idea di teatro nella diluizione dei nomi parlanti, nell’orgia di una carne famelica che il teatro pretende di dire e di salvare dicendo, proferendo. Per questo, nei suoi testi, le orecchie sono così spesso citate, evocate, chiamate alla scena. Le orecchie, ovvero le parti del corpo più aperte all’esterno, volti inguardabili dell’ascolto, che Novarina invoca perché attraverso le orecchie si formi quell’unico teatro possibile della parola: un soffio che si trasforma in voce e che si ri-trasforma in suono nel suo presentarsi alle buche esterne del capo, della testa, questo tappo poggiato sul totem dell’uomo-trou, del nome poggiato su un “buco” attraverso il quale passa il dolore della vita”.
E questo dolore, che permea la scrittura di Novarina eretta contro ogni forma di comunicazione, passa dalla pagina alla scena attraverso l’ecolalia e la filastrocca riaffermando, al di là del senso, la sovranità del suono sorgivo.
Prefazione all’edizione italiana di l’Atelier Volant di Valère Novarina, L’atelier volante, Costa &Nolan, Milano 1998.
Con il contributo del Centre National du Livre.
“Essere attori non è amare l’apparire, è amare enormemente scomparire”
Questa frase racchiude in sé l’atmosfera del teatro di Valère Novarina. La Francia è la terra della declamazione drammatica, della custodia delle tradizioni (basti pensare alla Comédie Française, tempio del teatro classico); ma è anche un paese nel quale il teatro è vivo, un paese di grandi attori, grandi registi, nuovi autori. Nel panorama francese contemporaneo Novarina occupa un posto decisamente originale: la sua scrittura è caratterizzata da una ricerca tanto complessa quanto rigorosa che si interroga sui fondamenti della lingua e sul ‘mistero’ rappresentato dal corpo dell’attore che, varcando le quinte, diventa un essere ‘non di qui’ , un essere altro. Lontano dall’idea di ‘spettacolo’, Novarina scrive per il teatro, e sperimenta la sottrazione di elementi. Vuota il palcoscenico e va oltre la distribuzione dei ruoli, delle battute: in scena ci sono voci, nomi, immagini che non debbono legarsi a personaggi, situazioni, intrighi. Togliere elementi è un modo per concentrare energia, e per far splendere in scena l’evento oscuro e misterioso costituito dalla presenza dell’attore.
Quando, nel 1992, il Festival d’Automne di Parigi ha presentato la versione per la scena di Je Suis, il palcoscenico del teatro era un grande spazio vuoto, occupato dalla parola. Valère Novarina ha inaugurato un teatro di figure orali: i personaggi hanno perduto la loro centralità e al loro posto una folla di nomi e di numeri è arrivata ad occupare prima la pagina e poi la scena, creando alcune costanti che permettono di capire le modalità compositive del suo teatro: la ripetizione, la nominazione, la numerazione.
La ripetizione è un modo di dare corpo ad una parola dissolvendone i connotati semantici. Nella ripetizione si può arrivare ad una tecnica divinatoria della scrittura: il termine ripetuto infatti finisce col perdere il proprio senso per restare solo nella sua veste sonora. Più la ripetizione è lunga più il potere sonoro acquista una forza impressiva. Si stampa nella memoria come ricordo orale, che crea una zona di vuoto del significato per lasciare spazio ad un pieno di lingua.
La nominazione è una forma di chiamata alla voce delle cose: Novarina mette al mondo le figure orali del suo teatro e dà loro un corpo, nominandole. Nel corso degli anni i personaggi dei suoi testi sono aumentati enormemente: sono presenze orali pure, che compaiono per esistere in voce e nella voce scompaiono. Nell’Atelier Volant (1968) erano otto, nella Chair de l’Homme (1995) compaiono tutti i nomi propri esistenti in francese. In un testo dal titolo L’unica passione dei numeri, Novarina ha scritto: “Non chiamiamo le cose come sono, le chiamiamo perché siano”. Ma accanto ai nomi ci sono altre presenze che proliferano via via. Si tratta dei lunghi elenchi di fiumi, di piante, di uccelli. Il loro corpo è nel loro ritmo: creano, in pagina come in scena, gorghi di energia che tengono insieme il testo o lo spettacolo.
Infine, la numerazione, che forma un’aura, un alone che circonda le cose, le parole in scena. Numerando, la parola trova nello spazio la sua disposizione, si ordina, si compone, si placa. Ogni numerazione vorrebbe arrivare fino alla fine, quindi è destinata a fallire. I numeri che si incatenano l’uno all’altro sono cantici mancati e condanne alla perpetuità. Numerando, Novarina dissemina cifre per ritrovare segni del suo passaggio, per non perdersi nelle parole.
Queste tre modalità compositive lanciano nello spazio dei frammenti di lingua per far vivere in scena o nella pagina esseri orali che esistono unicamente nel fiato dell’attore-tubo, quel “corpo cavo” che trangugia ed espelle la parola dell’autore, rigenerandola nel suo souffle, nel suo respiro.
L’attenzione di Novarina per la dimensione orale della scrittura affiora quando si scopre un endecasillabo nascosto, una rima, un gioco di assonanze. Questa scansione non è mai un ornamento formale: è una tecnica divinatoria della scrittura che serve ad evocare, e quindi a generare, nuove forme. L’unica azione possibile, secondo Novarina, è il parlare, e la lingua non è un attrezzo, non è uno strumento. E’ la struttura stessa, la materia di cui siamo fatti. Novarina ha detto che “ogni parola è un dramma” ed è questo il motivo per cui i suoi testi possono essere definiti “drammi di parole”. Ma qual è il dramma cui pensa? E’ il fatto che poi, dopo, la parola si tacita. Tace. Muore. Ogni parola è quindi un confine, un passaggio, un limite. Oltre il quale ci aspetta il silenzio. Ma Novarina crede che “i libri, tutti i libri, sono vuoti, morti. Per farli rivivere bisogna respirarci dentro, rianimarli con il souffle”. Questo è ciò che fa l’attore: dà vita a parole morte. Tutte le parole autentiche, nascendo, hanno destato stupore, hanno rivelato qualcosa, forse hanno provocato un piccolo scandalo, un breve amore, un’intuizione esatta. Col tempo, le parole non sorprendono più: ogni parola, anche la più audace, perde il mordente e resta lì, contemplabile, inerte. E’ la cosa che fu, ora innocua, muta, morta.
Tutte le lingue, secondo Novarina, sono morte. Per questo torna così spesso sul termine ‘scavo’: non gli interessa cambiare l’aspetto delle parole, lavora sulla loro struttura. Quando inventa un termine, quando scandisce una pagina, quando crea echi di assonanze fra i paragrafi, quando tesse una trama di richiami fra i nomi o fra le voci della scena, in ciascuno di questi casi si sente, già nella lettura, che non c’è alcun virtuosismo: è un modo per rendere al francese una vita autonoma, scavando e tagliando sotto la sua pelle morbida, liscia e ben curata.
Lo scavo è quindi una forma di creatività linguistica, è lingua che si crea, che cambia corpo per ritrovare il suo flusso interno, il suo sangue, il suo respiro. Ogni neologismo è rinascita di un termine: dall’argot, dal savoiardo meno contaminato, dal latino, dalla botanica o da antichi linguaggi magici, Novarina estrae un cuore di senso attorno al quale nasce la nuova parola. Non c’è invenzione, ma rimessa in vita di parole morte, o perdute. Quindi, ogni parola ‘nuova’ è nata dall’ascolto e solo dopo è caduta nella pagina che le ha dato il suo nuovo corpo. Ma non è mai una parola ‘ben messa’: deve avere le sue ombre, le sue reticenze, il suo mistero. Novarina vuol rendere al francese il peso, gli strati e la complessità che ne hanno fatto, nei secoli, una delle lingue più belle del mondo.
Il primo testo di Valère Novarina risale al 1970. Si tratta dell’Atelier Volant, che mantiene ancora la scansione classica in atti e scene e nel quale il numero dei personaggi è ancora ‘ragionevole’. Ma, già lì, il problema della lingua è centrale: i due padroni Boucot e Madame Bouche controllano il lavoro e il tempo libero dei loro sei operai . Il loro è un microcosmo perfettamente funzionante e chiuso. Ma perché questo meccanismo funziona, cosa assicura il mantenimento della situazione esistente? La lingua, o meglio la padronanza della lingua. Chi la possiede, ovvero i padroni, fa di tutto per non condividerla, e la usa come strumento per manovrare: ogni conflitto è messo a tacere dalla lingua che comanda, che non ha alcun interesse a comunicare con la lingua comandata e quindi tende a complicarsi, a erigersi, a camuffarsi, a diventare impraticabile e ripida. Questa lingua non è solo il discrimine fra i ceti ma diventa il mezzo più potente per manipolare la realtà. Dopo L’atelier Volant Novarina ha continuato ad esplorare poteri e potenzialità della lingua.
Nel Monologue d’Adramélech, che risale al 1978 e che Novarina ha scritto per il suo attore d’elezione, André Marcon, è possibile individuare l’origine di un cambiamento importante. Infatti, Adramélech è il primo testo per attore solo, che fa parte dell’unica opera mai andata in scena, il Babil des Classes dangereuses. Dalla proliferazione di immagini, corpi orali e nomi emerge Adramélech, che, nella sua incompiutezza, ‘afferra’ la parola. Non la domina ma la prende, e la tiene per 25 pagine. In questo caso il monologo rappresenta la liberazione dal dominio della lingua egemone ed è un esercizio da fare d’un fiato, senza smettere mai, lanciandosi in apnea. Dopo Adramélech Novarina ha scritto altri due testi per attore solo: L’inquiétude e L’Animal du temps, entrambi del 1992. Sono due differenti versioni per la scena del Discours aux animaux (1987). Fra Adramélech e questi due testi sono passati 14 anni, e la differenza principale nella scrittura può essere rintracciata nel fatto che adesso il monologo non è più la conquista di uno spazio orale, non ha più una funzione liberatoria, non è sfida alla lingua da parte di una parola sorgiva e quindi necessariamente ‘inabile’. E’, invece, corpo che si materializza nella parola, soliloquio rivolto a chi ascolta nel suono la vita che questo contiene. In questi ultimi due testi la lingua si contempla in se stessa, gioca con il proprio corpo generando forme tonde, ascolti pastosi, immagini orali potenti.
Vous qui habitez les temps (1989) appartiene ancora al genere ‘testo drammatico’, ma questa aderenza è più apparente che reale. Le convenzioni sceniche e drammaturgiche sussistono per mettere a nudo le loro debolezze. Non è più possibile parlare di personaggi: le apparizioni orali che entrano e scompaiono seguono logiche completamente sganciate da qualsiasi esigenza narrativa. Vous qui habitez les temps è una interrogazione sui limiti dell’azione drammaturgica e sulle possibilità della scena teatrale. E’ un testo dedicato all’attore, ma non ad un attore qualsiasi: all’attore-tubo che, smembrato anch’esso, diventa suono, eco, nome, corpo cavo che ospita la parola dell’autore.
D’ora in poi l’elemento coagulante della scrittura di Valère Novarina diventa la filastrocca che, nel suo ritmo costante, riesce a raggiungere uno stato di purezza creativa: come nella ripetizione di un termine si finisce col sentirne solo il suono perdendone il significato, così nella filastrocca la lingua diviene puro ritmo, scansione, danza di suoni che rigenerano il senso nella loro andatura orale. Nella filastrocca, o, in alcuni casi, nella litania o nella preghiera, Novarina ripete, con variazioni minime, una frase, una struttura, una melodia. Questo lo porta a raggiungere un uso incantatorio dei numeri e dei nomi, che si rinnovano nella ripetizione.
Nei due scritti sul teatro, Le Théâtre des paroles (1989) e Pendant la matière (1991), in forma di aforismi, di imperativi, di appunti o di lettera Novarina ha esplorato a fondo la fascinazione che l’attore suscita in lui, analizzando il rapporto fra questi e il souffle; si è interrogato sullo “scambio respiratorio” che avviene nella lettura, si è posto domande sullo statuto della scena, ha raccontato il “sistema di interdizioni” che è alla base della sua scrittura, ed ha condannato la televisione con la lapidaria immagine di “cattedrale del XX secolo”. Ma, soprattutto, ha detto di divorare le parole, come i suoi personaggi. Mangiare parole equivale per lui a mangiare corpi, perché questi non sono visti nei loro caratteri fisici, nella loro specificità corporea. Gli attori che si cibano di loro stessi si nutrono dell’unico corpo a disposizione, quello della parola, che è appunto un “boccone”.
Il cibo ha assunto un ruolo sempre più importante: dopo il lungo pasto dello Spazio furioso, nella Chair de l’homme (1992) il banchetto è diventato orale. I commensali sono ciò che mangiano e si chiamano Mangeur Coriace, Mangeur Correct, Jean Mangeoire. Nella proliferazione di nomi del teatro di Novarina, in questo testo i mangiatori sono diventati seimila, seimila nomi affamati dell’unica carne possibile che è sempre la parola. Uno di loro lo dice: “Il sacrificio di una parola accade ogni volta che io parlo”. E l’ultimo spettacolo di Valère Novarina, ospite del Festival d’Automne 1996 con la regia di Claude Buchwald, si chiama proprio Le Repas, il pasto.
La scrittura di Novarina ha reso possibile trattare la lingua diversamente, non solo liberandola dai legami sintattici e grammaticali, ma anche conferendole un potere generativo e di smembramento che mai le si era attribuito. L’idea che la parola possa mettere al mondo nominando, e che sia in grado di ricostituire con l’enunciazione la forma delle cose ha fatto sì che nel teatro di Novarina si sia verificata una inversione importante: i personaggi non sono più ruoli per attore, ma apparizioni orali.
E’ proprio la ricerca della pulsazione autentica, che al principio era in tutte le lingue, il desiderio di liberarla dall’unico silenzio spaventoso, quello delle parole vuote, che spinge Novarina a scavare sempre più a fondo, in una scrittura che scuote i fondamenti della lingua per ritrovare il fondo della parola.
Nota di traduzione
“Come, come, come? Perché si è attori, eh?
Si è attori perché non ci si abitua a vivere nel corpo imposto,
nel sesso imposto.
Ogni corpo d’attore è una minaccia, da prendere sul serio,
per l’ordine dettato dal corpo, per lo stato sessuato;
se un giorno si finisce a teatro è perché c’è qualcosa
che non si è potuto sopportare.
In ogni attore c’è qualcosa che vuole parlare, come un nuovo corpo.
Un’altra autonomia del corpo si fa strada,
e scaccia la vecchia economia imposta”.
Valère Novarina scrive all’attore, per l’attore. I testi sono popolati di nomi e di apparizioni e vi si incontrano figure di lingua, le cui parole sono di carne. Si può dire che la carne dei suoi personaggi è costituita dalle loro parole, che montano e smontano il mondo chiamando e nominando.
Eppure questa parola non appartiene al personaggio, non è l’espressione della sua psicologia e della sua azione. Al contrario, è il personaggio ad appartenere alla parola. Il teatro di Valère Novarina non è quindi un teatro di personaggi, è un teatro per attori. Tutto il conflitto orale che mette a confronto lingua e parola è, in realtà, un dono all’attore.
Sfogliando i vecchi vocabolari, leggendo i testi che hanno lavorato sul respiro ampio e gli autori che sanno “scrivere con le orecchie”, Novarina condanna una lingua muta dal troppo parlare. La lingua francese è divenuta un’odalisca pigra, grassa e miope, esausta di non dir nulla. Adagiata su divani damascati, fra dopocena e thé pomeridiani, ha perduto la memoria delle origini e l’agilità che la vita richiede.
L’operazione di Valère Novarina consiste nello spogliarla dai vizi che un troppo lungo benessere le ha conferito. Ma il desiderio di violare la lingua non è desiderio di creare uno stile, un timbro riconoscibile a distanza. Novarina ha nostalgia di una unità oggi definitivamente perduta: l’unità corpo-voce, che si esprime in una pienezza pastosa, in un flusso parlato e respirato che esce dal corpo nuovo ogni volta, che cerca ogni possibilità di apertura, di scavo, di vertigine.
E’ innanzitutto uno scavo nel francese, alla ricerca di una oralità non rigida, di una parola capace di riscoprire il suo potere generante e la sua forza visionaria.
Quando si decide di uscire dalla propria lingua per accogliere la lingua di Novarina, di ascoltare il movimento orale piuttosto che seguire il senso, quello che avviene è innanzitutto un incontro. Fra le lingue. Fuori da sé. Perché fra le lingue, quando le si libera dalle loro regole e dalle loro abitudini, si produce qualcosa di sorprendente: un richiamo verticale fra le parole che permette scoperte inattese. Dai luoghi più nascosti riaffiora la loro vecchia radice comune, che un tempo era percettibile, e che ricompare quando si tratta di ascoltare piuttosto che di cogliere.
La prima cosa che colpisce, leggendo un testo di Novarina, è il modo in cui l’ascolto si impone: ci sono come dei richiami ad eco che trascinano la lingua fuori dal tracciato abituale, e ci si ritrova in un percorso orale fatto di ispirazioni, di pause, di movimenti legati fra loro. Valère Novarina è alla ricerca di una scrittura vocale che possa accorciare la distanza fra la pagina e la gola, fra la grafia e l’emissione. E’ lontanissimo dal gioco di parole, dal calembour e da ogni virtuosismo: dietro ad un neologismo c’è sempre una etimologia da cercare, un’antica parola, una radice profonda che possiede legami precisi con una lingua, una regione, un dialetto. Si tratta ancora una volta di ascoltare e di ritrovare il motivo che ha fatto cadere la parola proprio in quel punto della pagina. Perché le onde provocate da una parola creano la vibrazione dell’intera frase, chiamano altre parole, si legano in cerchi sempre più larghi costituendo fra loro un legame intimo che chiede intimità per svelarsi.
La lingua si spoglia dolcemente, silenziosamente, nell’ombra protetta della non ripetizione, e rivela un corpo brillante, luminoso, ricco e inedito che induce al silenzio e alla contemplazione.
Nel caso della traduzione, cosa fare per salvare questo “corpo”? Innanzitutto si tratta di cercar di rendere percettibile nella lingua tradotta il movimento segreto del francese, perché il movimento di una lingua è parte del suo corpo. Le parole producono una rete di senso e stabiliscono fra loro legami che appartengono unicamente a quella pagina e non ad altre. Ogni parola emana qualcosa e, toccando le altre, le modifica.
E’ quindi un errore immaginarle le une accanto alle altre, pronte al viaggio da un libro all’altro. Non avranno né lo stesso senso né lo stesso suono dopo aver compiuto il viaggio. Michel Foucault chiama queste trasmigrazioni di caratteri “traduzioni laterali”, nelle quali masse di senso e di suono scivolano in una nuova lingua passando attraverso un metal detector che le spoglia dei loro elementi. Ne escono pulite, neutre, anonime.
Je Suis, di cui Lo spazio furioso rappresenta la versione per la scena, aveva una diversa scansione dei personaggi. Comparivano la Logique e la Grammaire, che dissertavano sulle figure del discorso. Il Docteur Plenier e il Docteur de Vacuité esaminavano varie modalità di smembramento e dissoluzione del corpo e del linguaggio. Altri personaggi avevano il nome degli attori che li rappresentavano in scena, suggello dello speciale rapporto di Novarina con l’attore che trangugia il personaggio per sputare in scena carne orale dosata dal respiro e dalle pause.
Lo spazio furioso rappresenta l’ultima cesura, l’ultimo taglio di un lavoro che ha fatto della sottrazione il suo elemento caratteristico.
Tutta la drammaturgia di Valère Novarina è un conflitto orale, alimentato dal fatto che ogni parola sia, in se stessa, ‘un dramma’. La pagina, quindi, racchiude in sé tutto il teatro del mondo.
Per cogliere tutto questo noi dobbiamo spogliarci della nostra lingua, e riapprenderla ritrovando quelle correnti, quei gorghi e quelle assonanze che Novarina cerca nelle pagine del passato e che magicamente, da uno scaffale all’altro, gli antichi volumi continuano ad offrirgli durante i suoi vagabondaggi fra le parole.
Presentazione dell’edizione italiana di l’Espace furieux di Valère Novarina, Lo spazio furioso, Costa & Nolan, Milano 1996.
Con il concorso della Fondazione Beaumarchais
All’attore è l’unica raccolta di scritti sul teatro di Valère Novarina.
La lettera agli attori, scritta in una notte durante le prove de L’Atelier volant, è un proclama e un atto d’amore: certificato di nascita dell’attore “pneumatico” e di un linguaggio che è soffio vitale, respiro della scena. Il dramma nella lingua francese è un quaderno di lavoro dove la lingua è smontata e rimontata secondo cadenze, assonanze, false etimologie, lessici parascientifici: un atelier verbale a pieno ritmo. Taccuini è un diario di bordo sulla cerimonia della lettura in pubblico. Contiene maniacali riflessioni sulla voce e sulla posizione del corpo, note sulla concentrazione e sul rilassamento. Il Teatro delle orecchie racconta in terza persona il viaggio nella lingua francese e gli esercizi quotidiani di una scrittura che vuole scendere sempre più in basso nel suono e nel senso. Imperativi è una lista di 288 “avvertimenti” dati a sé stesso per la stesura dei testi teatrali: appunti, riflessioni, soggetti minuscoli, drammuscoli di parole, evocazioni di personaggi, note sullo stile, la sintassi, il lessico. Per Louis de Funès è un omaggio all’attore e al suo funambolico gioco con la luce e la morte. Caos è un breve saggio su Rabelais, sul grande corpo della madre-lingua e sulla lettura come tecnica respiratoria. Infine, La nostra parola: comincia con un’invettiva contro il mondo contemporaneo, preso in ostaggio dalle merci e dalla televisione, e finisce con la celebrazione della parola, unica forza vitale qui contrapposta a quello scambio comunicativo piatto che trasmette solo morte.
Novarina chiama cailloux, “sassolini”, quei frammenti verbali che vengono rimasticati nella bocca e nel cervello. Allude ad una pratica creativa che non distingue i diversi stadi dell’invenzione e della riflessione. Sono “sassolini” le piccole ossessioni tematiche, le parole-flash, i ritornelli mentali, i nomi, le litanie, i numeri, gli elenchi, i suoni e le onomatopee, il ritmo e i minuscoli personaggi che scaturiscono da un dizionario universale dei “nomi del mondo”.
Tradurre testi così elaborati e composti in “lingue diverse” pone un problema particolare: bisogna trovare l’equivalenza del suono e del senso, del ritmo e dell’invenzione linguistica, degli stili molteplici e della loro visibilità sulla pagina trattata come un palcoscenico.
Nelle numerose sedute di lavoro con Valère Novarina si è a poco a poco messo a fuoco un metodo: trasferire in italiano il lavoro della scrittura, l’atelier sonoro e ritmico del francese. Un ulteriore problema era costituito dalla necessità di far affiorare quei saperi linguistici del passato che Novarina cita segretamente o rielabora in speciali camuffamenti lessicali e stilistici.
Inventore di parole, rabdomante di espressioni arcaiche, collezionista di termini astrologici, teologici, medici e geografici, Novarina usa la polvere verbale delle bancarelle dei quais parigini e le assonanze ingiallite dei vecchi dizionari, bestiarî, erbarî, enciclopedie universali.
La costruzione linguistica non è solo contaminazione di forme lontane nel tempo e nello spazio, ma fusione di elementi restituiti a nuova vita. Per questo, ho scelto un lessico misto, fatto di echi di italiano antico e di spezzoni di italiano attuale molto manipolato, per ottenere una equivalenza di fondo, invisibile ma ascoltabile, fra il francese di Novarina e l’italiano della traduzione. Il pastiche, in Novarina, non è un gioco di maniera, ma una creazione drammatica di corpi linguistici viventi.
Per rendere questa tecnica particolarmente seria del pastiche, ho crecato risonanze lessicali e gergali che permettessero al lettore di ascoltare il movimento della lingua francese sotto la lingua italiana.
Bisognava trovare, a questo punto, anche un equivalente ritmico tenuto in sottofondo. Ho adottato, dove possibile, lo schema dell’endecasillabo nascosto nella prosa, e comunque una scansione secca e un gioco di pause che restituissero le diverse pulsazioni della scrittura di Novarina. Infine, le invenzioni linguistiche vogliono essere un plausibile calco dell’originale, fabbricate in un italiano che lasci intravvedere gli atti di creazione linguistica dell’autore.
presentazione dell’edizione italiana di Le théâtre des paroles, di Valère Novarina, All’attore, Pratiche, Parma 2002.
A CB sono parole nate quando la voce di Carmelo Bene si è spenta, nel marzo scorso. Dei suoi amici, di coloro che con lui hanno pensato le scene e le luci, le musiche e l’immagine della sua arte. Molti, che gli sono stati vicini, mancano. Nel 2003, l’invito della fondazione l’Immemoriale a pubblicare questi testi ne ha fatti nascere di nuovi, cui si sono aggiunte, offerte dai fotografi, le immagini. A coloro che hanno dato una diversa immagine di Carmelo Bene va il nostro ringraziamento, e anche alla fondazione Romaeuropa, che ha accolto l’idea di rendere sulla sua rivista un omaggio diverso a CB.
Diverso perché la maschera pubblica tanta ombra dava alla sua limpidissima visione, alla sua lucente opera, alla sua voce struggente, a quel gusto di vivere appartato fra l’edera, gli angeli di gesso del Bernini, i broccati, gli argenti, i cristalli delle sue lunghe notti. Carmelo Bene era turco come i tramonti sul Bosforo, senza cuore come chi lo ha maciullato. Ma era anche amorevole, fedele, generoso. E tutto questo, come ha scritto Jean-Paul Manganaro, di lui non si sa. Tutto questo è deposto nelle parole che sceglieva, nella perfezione delle scene, nella cura dei dettagli. In quella trama di letture, di conversazioni e di ostinata ricerca che solo chi ha lavorato accanto a lui, chi lo ha visto provare, chi con lui ha cenato o chi ha avuto la fortuna di tacere quando non capiva, aspettando di capire, solo loro sanno e possono dire. Carmelo non c’è più. Resta la sua casa. Restano registrazioni, video, film, immagini, scritti, fotografie, trasmissioni. Restano le sue cose, i bei libri letti e annotati, le lampade con le perline, i quadri di Klossowski, i costumi, i velluti doppi. Resta la sua idea del teatro, così in anticipo da non essere ancora compresa. E resta ciò che ha lasciato a ciascuno, che torna improvviso. Il fotografo Sandro Becchetti, dandomi la bella immagine di CB che è in queste pagine, mi ha detto: “Sa perché Carmelo amava incondizionatamente le donne? Me lo disse quel giorno: Perché sono la cosa vivente più vicina alla morte”.
E in Laforgue, in Gozzano, in Leopardi, in Majakowskij, in Dante, in Shakespeare, in Collodi, in Camus, in Marlowe, in De Musset, in Cervantes, in Benelli, in Prévost, in Hölderlin, in Stazio, in Jarry, in Kleist, in Teofilo Folengo Carmelo Bene ha sempre cercato, nella loro paura di morire, la sua ragione di vivere.
A C B, a Carmelo Bene, Editoria e Spettacolo
con interventi di
Jean-Paul Manganaro, Camille Dumoulié, Antonio Attisani, Sandro Lombardi, Romeo Castellucci, Achille Brugnini, Silvia Pasello, Mauro Contini, Doriano Fasoli, Elisabetta Sgarbi, Gaetano Giani-Luporini, Gioia Costa, Giancarlo Dotto, Michela Martini, Sonia Bergamasco, Renato Nicolini, Paolo Puppa, Piero Bellugi, Paolo Pelliccia, Tiziano Fario, Franco Cuomo, Rino Maenza, Enzo Moscato, Alfonso Santagata, Lisa Ferlazzo-Natoli, Davide Iodice, Davide Riboli, Luca Buoncristiano, Enrico Ghezzi, Maurizio Grande, Piergiorgio Giacchè
La favola di questo mondo
Con Daniel Danis appaiono in scena archetipi dell’infanzia e dell’innocenza irraggiungibile che raccontano con semplicità solo apparente tutto il dolore di vivere, e la dolcezza che si cela nel dolore.
È questo il filo attraverso il quale leggere l’esistenza dei suoi personaggi, quasi sempre bambini, che devono subire continue prove per liberarsi dall’universo punitivo rappresentato da ciò che sfugge al loro controllo: l’Ordine e la Legge. La salvezza è possibile a condizione che vengano riconosciuti i valori che, soli, sono in grado di aprire l’angusta sfera d’azione concessa ai minuscoli eroi della modernità. Non è un caso che l’amicizia occupi un ruolo centrale: può essere fonte di vita o di morte, ma si presenta sempre come slancio profondo di ogni azione, centro attorno al quale costruire la trama della propria vita.
Infatti le esistenze di tutti i personaggi di Danis, benché divise fra violenza, paura e fantasia, sono tenute insieme da una forma moderna di fede: la fede nel sogno intimo di ciascuno, realizzabile solo attraverso un volere incondizionato e fermo. Impossibile costringere le sue creature nei confini del bisogno e del dovere perché vivono tutte una vita altra, segreta e ricca di visioni, una vita dominata da un’idea che contiene la forza del progetto rigenerante. Il nuovo inizio, la rinascita, assume cosí un potere catartico e motiva il corso dell’esistenza dei personaggi.
Daniel Danis affida a una scrittura che non teme il lirismo le scansioni della sua pagina. Il movimento è dettato dal ritmo interno delle parole piú che da virgole o punti. Spesso ripete una frase, una formula, un’immagine. E questa ripetizione dà alla sua scrittura una connotazione emotiva.
Ciò nonostante, il teatro per Danis ha luogo innanzitutto nella parola e il racconto diviene visione di quanto si narra: le sue storie si nutrono di elementi semplici che hanno però una forte valenza mitica, ed è per il loro tramite che ricostruisce la complessità dell’essere e del suo volere.
Ecco perché il racconto assume in scena un valore visionario potente: le lacrime che sanno di limone, l’oggetto di rame nel quale soffiare parole, il corpo-lucciola che si illumina la notte, la pietra fra le costole che rende il cuore dolente, i corpi che lacrimano di fronte alla sofferenza sono immagini che avvicinano tutte il linguaggio alla pelle e la metafora al corpo, mostrando il lento movimento con il quale il teatro cambia sintassi senza dimenticare la sua natura prima: arte del racconto, della suggestione e del magico.
Nel giugno 1999, in occasione di un soggiorno organizzato dal Centro Internazionale di Scrittura Drammaturgica La Loggia e dall’Ambasciata Canadese al fine di rivedere le traduzioni, Daniel Danis ha scoperto le nuove sembianze che le sue immagini assumevano viaggiando da una lingua all’altra. Ospiti della Casa degli Alfieri ad Asti passeggiando fra le rose antiche, cespugli di rosmarino e di lavanda che mai aveva visto in Canada, con Daniel Danis abbiamo discusso a lungo dell’origine e della genesi delle sue immagini. Per ricreare il ritmo della pagina a volte è stato fecondo alterare l’ordine della frase e far affiorare, in italiano, forme dell’imprecazione, della rabbia o dell’intimità che permettessero di sentire, nella traduzione, il movimento originale del francese parlato nel Québec. Altre volte un’immagine assumeva, in italiano, nuove potenzialità da far affiorare. I segreti legami che danno a una parola un riverbero di senso in una pagina possono creare una nuova rete di suggestioni passando in un’altra lingua: diversa è la percezione dello spazio, diversi i gusti dei cibi e i colori delle stagioni. Diverso, in ogni caso, il modo di abitare la lingua. Ma in queste differenze affinità segrete e consonanze impreviste davano vita a piccole e grandi scoperte, a incontri linguistici, epifanie e metafore che hanno arricchito di nuova linfa le opere.
Parte di queste osservazioni ed analisi possono avvicinare il lettore italiano a una scrittura che racchiude in sé elementi violenti e teneri, forme nuove ed antiche, una fantasia libera accompagnata da un senso profondo della sofferenza.
Ad una prima lettura sorprende la ricorrenza della morte nei suoi testi. Minacciata, già avvenuta, incombente. Si manifesta come dono che la lepre fa di sé ai bambini affamati nel Ponte, è allegorica nel Canto del Dire-Dire perché in realtà apre le porte del Castello di luce. È simulata in Cenere: fingersi morti per spezzare tutto. Ma è anche reale, violenta: il sacrificio della mucca in una notte orgiastica. Cosa induce in lei questa continua interrogazione della morte, che è sempre legata all’immagine del sacrificio?
Camus ha scritto che “non vale la pena suicidarsi perché ogni giorno si muore e si rinasce ad altro”. La morte è rinnovamento. In questo senso può essere un dono.
Ogni religione che possieda il senso del sacro – non del religioso, del sacro – ha in sé gli elementi che contengono il cuore della mia sete, della mia ricerca: il legame profondo che unisce la sessualità, la natura e la morte. Tre elementi indissociabili. Tre cuori di vita.
Ho avuto un’educazione cattolica e la mia infanzia è ricca di ricordi legati alla chiesa, ricordi che si sono nutriti di fantasie, di immagini, di parole dette nelle preghiere della sera, subito prima dell’arrivo del sonno. Il dormiveglia ci porta al di là di quello che la fantasia “educata” osa immaginare, e spalanca nuovi orizzonti. Cosí, ho creduto fermamente che fosse possibile trasfigurare il mio corpo in altro: il corpo non poteva essere confinato alla realtà fisica, all’immanenza. La prima grande favola della nostra infanzia è il racconto della vita di Cristo, che mi suggeriva una diversa percezione della realtà. Provi a pensare, ad esempio, alla sua morte. È la prima immagine di morte che si forma nella fantasia di un bambino di religione cattolica, ed è un incontro con la morte simbolico, non certo reale. Questo mi ha permesso di guardarla da lontano, senza rapporti con il dolore della perdita di qualcuno. Perché in realtà il potere della morte è il potere dell’assenza. Da quel momento regna il mai piú, che si tramuta in destino.
Parliamo del Ponte di pietre, che contiene elementi mitici forti. Qui i corpi si tramutano in alberi carichi di frutti, i lupi offrono le loro pelli per dare calore, gli animali “diventano morti” per trasformarsi in cibo. Tutto questo ha una forte valenza religiosa.
Il Ponte è rivolto ai bambini e quindi dovevo semplificare il rapporto dei punti di vista all’interno della storia. Ho cercato un’immagine fondatrice: due esseri ingenui, cui per età è negata qualsiasi forma di astuzia, devono passare attraverso prove che non intaccano la loro morale e il loro cuore. Prove che permettono di vedere chiaramente oltre i valori adulti riscoprendo, in modo forse fiabesco, una terra dove ricominciare una nuova vita e un luogo dove alla fine tutto è possibile.
In questa visione è contenuto un messaggio “messianico”, tanto piú dure le prove tanto piú alta la ricompensa attesa? Il tema del dolore rigenerante è centrale per questo?
Sí, è centrale nella mia scrittura. Nel Canto del Dire-Dire c’è una componente di esperienza vitale reale ed intensa che porta a un’altra comprensione, oltre il linguaggio, oltre la parola. Un sapere. Non conoscenza ma sapere. È un’apertura. I personaggi non muoiono. Si svegliano attraverso il dolore. Nel Ponte di pietre, in Cenere di sassi, ma in fondo anche nel Canto del Dire-Dire, c’è la scoperta di un nuovo luogo e di un nuovo stato. Che si raggiunge attraverso prove, prove che permettono di accedere ad altro. E ogni cambiamento profondo passa attraverso l’esperienza del dolore. Il vero dolore è muto, fermo, vigile. In apparenza. In realtà, dentro, il dolore grida, si sposta e non vede. Ma la sua manifestazione esterna è la pietra. Per questo i cimiteri scelgono la pietra.
Nel Canto del Dire-Dire il centro è la parola: imparare a parlare. I personaggi sembrano obbedire a “necessità fantastiche” che dettano l’ordine della storia. Qual è la genesi dei loro caratteri?
Il canto del Dire-Dire è nato attorno al tema di come un uomo potesse far cantare il proprio animo. I tre fratelli sono legati all’immagine della trinità, sono tre aspetti spezzati dell’Uno. La sorella, Noema, rappresenta invece la pulsione di vita. Rock è la testa. Lui può decidere, far fronte alle difficoltà. È il solo che guidi, che vada all’ospedale, che sia presente quando è davvero necessario. William è la parte energetica sessuale, brutale. È energia arcaica, vuole infatti prendere il potere e scatena la violenza, ma non può dirigere la vita dei fratelli perché non ne ha le capacità. Fred-Gilles è l’ordine. È colui che può ricevere e restituire: può cucire, truccare sua sorella, cucinare. È l’unico che possa riferire quanto accade; per questo è il solo che, raccontando, ha diritto all’uso delle virgolette. Noema, infine, è il corpo addormentato in sé, che bisogna svegliare perché canti. Non ha rapporti con la realtà, quindi non risponde ad alcuno stimolo. Sposa il Tuono, costruisce il Castello di luce, canta come un angelo e, di notte, il suo corpo si illumina come quello di una lucciola.
Se il Dire-Dire è l’oggetto con il quale imparare a parlare, in Cenere di sassi il protagonista è invece chiuso in un silenzio violento: per superare il dolore della morte di sua moglie sceglie di non parlare piú. Questo testo apre una nuova fase nella sua scrittura: è il solo nel quale compaiono figure reali. Cosa la ha indotta ad allontanarsi dalle sue figure mitiche?
Cenere di sassi è il racconto di un’iniziazione. Inizia il mondo alla vita e alla morte. È nato attorno al tema del silenzio. Il silenzio è sempre legato a un dolore. I personaggi vivono un’esperienza vera, possibile, in questo testo, ed è la prima volta che ambiento un racconto in una situazione verosimile. Ma quello che mi interessa non sono i caratteri, né l’evoluzione della storia. È l’incontro violento fra la vita e la morte, che ogni nuova esperienza produce e genera.
La vita è un’avventura globale e pericolosa: ogni sua manifestazione è sensuale e proprio per questo nasconde la morte. La natura, tutta la natura, è pura sessualità, ovvero energia, come l’acqua, la terra, il ghiaccio.
Dietro ai personaggi, dietro al loro volere, c’è il sentimento che comanda. E naturalmente il sentimento dipende dall’energia che li unisce. L’energia è sempre esplosiva, anche nel silenzio.
Pelli magiche, strumenti ovali di rame rilucente, pietre e rocce, medaglie dotate di poteri curativi. Qual è il ruolo degli oggetti nei suoi testi?
Sono loro che dettano la cristallizzazione delle immagini, che danno vita al racconto. Il rame che brilla dal rosso all’oro, e che può curare, le rocce… Le rocce mi hanno sempre affascinato. Ricordo di aver saputo da bambino dell’esistenza di gallerie sotterranee nelle quali lavoravano degli uomini per estrarre rame o zinco. Dove io abitavo la terra di notte tremava perché le mine esplodevano di notte per aprire nuove gallerie. Questa immagine per me era legata ai fondali del mare, alle profondità inesplorate, a quanto si può percorrere solo nell’immaginazione. Ma pensare a uomini che vivevano parte della loro vita sottoterra mi ha colpito profondamente. L’oggetto roccia in sé non mi interessa, non mi piacciono le collezioni, né tantomeno gli amuleti. È la materia che mi folgora, nell’insieme.
È cosí per tutti gli oggetti. Importante è il vetro della bottiglia, non la bottiglia in sé. La sua trasparenza, il fatto che sia fatta di sabbia, eppure sia trasparente. Come si può concepire veramente che il vetro venga dalla sabbia?
Le sua scrittura suggerisce un teatro destinato all’ascolto: si può pensare a una scena nuda nella quale un attore, con le sue parole, faccia apparire tutte le immagini. Vorrei che parlasse dell’origine del suo rapporto con il teatro.
All’inizio non è stato facile: non sapevo riflettere con le immagini, ne ero invaso, ma non sapevo come trasporle in scena. Poi ho scritto Celle-là, il mio primo testo. È nato come un dono, come un regalo di compleanno. Da allora tutto si è disposto semplicemente: le immagini hanno preso forma.
Il teatro è il luogo nel quale gli esseri umani si incontrano per sentirsi parlare. È il luogo profondo della parola. Parole sparse, immagini, storie. Ma dove si capta ciò che avviene in scena? Nel corpo dello spettatore. Esistono corpi che, incontrando parole, permettono di generare sogni che legano segretamente un’intera platea al medesimo percorso intimo. La sola frase che si potrebbe dire a teatro è: “È magnifico, viviamo tutti nello stesso momento”. Lo spettacolo può finire lí, ogni spettacolo. Uno scambio di corpo fra tutti in sala. È meraviglioso. Ecco. Ecco perché scrivo per il teatro.
Prefazione all’edizione italiana di Teatro di Daniel Danis, Oedipus, Salerno 2000
Le maschere della lingua
Alcuni autori possiedono una scrittura talmente connotata che ogni personaggio, ambiente, carattere diventa uno specchio del loro mondo. Altri invece escono dalla loro lingua per dipingere con le parole e la struttura situazioni ed esseri nati dalla fantasia. Alain Badiou ha scritto un testo che appartiene a questo secondo genere: una farsa in ventidue scene, tutte molto brevi, nella quale la lingua scorrendo nella bocca dei diversi personaggi cambia ritmi, colori, caratteri. I personaggi sono definiti dal linguaggio che ognuno di loro adotta come timbro vitale e che rappresenta il suo speciale modo di essere al mondo.
C’è chi è padrone dei segreti della sintassi, come Ahmed che parla il francese con più raffinatezza di coloro che lo possiedono per nascita e per cultura; chi, come Moustache, ha un linguaggio grossolano quanto le sue idee, fatto di pennellate pesanti e imprecise che vogliono imbiancare la Francia rispedendo a casa tutti gli “immigrazionati”; chi è corrotto dal linguaggio della propria categoria di appartenenza, come Madame Pompestan che, volendo conservare la sua posizione di supposto potere, oscilla fra una lingua spontanea non priva di arroganze e allusioni e il gergo politico più vuoto e impersonale; chi ancora è farraginoso e disorientato dalle ideologie, come Rabarbaro, che auspica fratellanze, giustizie e sodalizi onnicomprensivi con una confusione sintattica che riflette la sua confusione mentale; chi, infine, è assolutamente inaddomesticabile, come Fenda, la magnifica nera in bubu azzurro cielo ed oro, che nutre ogni sua frase di immagini lussureggianti, uccelli esotici, piante del deserto, metafore impreviste e acrobazie vittoriose: unico linguaggio libero, quello di Fenda, l’unico coraggioso e sincero, l’unico capace di tenere testa alle acrobazie e al virtuosismo di Ahmed. La presenza di personaggi così differenziati, ciascuno dei quali possiede un diverso idioma, fa di Ahmed il filosofo un testo nel quale la lingua ha un potere connotativo forte e un ruolo descrittivo determinante.
Questa piccola traversata delle lingue è, in realtà, una traversata del testo: perché ogni lingua è aderente al corpo e alla mente del suo personaggio, ne è lo specchio e l’anima, il mistero e il destino. Di tutti i personaggi l’unico ad indossare una maschera è Ahmed. Conferma, questa, che la maschera è ciò che rende possibile una grande libertà: con il volto coperto, ma coperto da un volto, Ahmed è il meno mascherato e il più mobile. A lui la libertà di dire, oltre che di parlare, a lui il compito di smascherare tutte le coperture, a lui la possibilità di capire, a lui, infine, l’occasione di ritessere e capovolgere con le parole le certezze di coloro che vivono nelle lingue pensate da altri. Ogni personaggio aderisce al suo ruolo, che lo vincola ad una immagine e ad un contesto più rigido di ogni maschera. Anche Fenda, che è l’unica a pensare e a leggere la realtà con la sua parola ricca di visioni, appartiene alle sue fantasie dipinte con i colori dell’Africa.
Alain Badiou, nel corso di alcuni incontri organizzati da José Guinot ad Avignone dove Ahmed il filosofo era ospite del Festival, ha detto che il suo desiderio era quello di scrivere un testo molto chiaro: “Come un’equazione matematica. E’ chiarissima, ma non è affatto semplice”. Dall’ingresso di Ahmed, nella prima scena, che dissertando sul suo non essere niente mette in luce arguzie ed abilità nel depistare l’interlocutore, al ‘gran finale’ in cui tutti i personaggi, per la prima volta insieme, compongono una orchestrazione densissima cercando di spiegare che cos’è la filosofia, nel corso di queste ventidue scene Alain Badiou delinea, adottando di volta in volta i registri dei diversi personaggi, l’importanza del pensiero libero e la felicità dell’espressione esatta. La struttura del testo è molto chiara: ogni scena ha un tema che è anche una occasione per discutere assiomi incontrovertibili della filosofia (nel “linguaggio” Foucault, nel “caso e la necessità” da Cournot a Monod, nel “soggetto” Cartesio) ed è lo spunto per mettere a confronto il potere del pensiero libero con i grovigli del luogo comune. Ahmed, signore del suo pensiero e padrone della sua lingua, capovolge ogni situazione, confonde il suo interlocutore, mette a nudo gli automatismi e i vizi di forma di chi tenta di accomodarsi in opinioni mal assimilate. Alain Badiou ha caricato tutti i personaggi per renderli più evidenti e per far apparire con maggior vigore la differenza fra chi vive in strutture altrui (grammaticali, politiche o sociali) e chi non ha alcun bisogno di strutture perché vive nella propria libertà. Il fascino di ogni traduzione consiste nelle sue difficoltà: ogni autore ha parole elettive, consonanze, reti di associazioni, invisibili orditi di memoria. Trasportare una lingua dal suo paese d’origine in una nuova terra è sempre un gesto delicato, che richiede ascolto e discrezione.
Tentare di ricreare i diversi gerghi dei personaggi di Ahmed il filosofo, i loro luoghi comuni, gli errori, le ingenuità, gli idealismi o le arroganze, è stata una avventura piena di sorprese e di scoperte: ciascun personaggio è realmente radicato nel proprio modo di esprimersi e assomiglia fisicamente al suo linguaggio. Scivolare in questa rete di possibilità vitali, adottando per ogni figura un differente spettro di parole, mantenendone i timbri ed il carattere è stata una affascinante traversata fra le lingue, una affascinante scommessa con la propria.
Prefazione all’edizione italiana di Ahmed philosophe di Alain Badiou, Ahmed il filosofo, Costa &Nolan, Milano 1996.
La frase appena socchiusa…
A volte, quando lascia intravvedere qualcosa di imprevisto, la scrittura genera un mondo, con tempi e modi mai immaginati. Jean-Luc Lagarce ha questo raro dono: nelle cinquecento pagine del suo diario, appuntate fra caffè, viaggi, o di sera tardi nei piccoli alberghi, traspare la sua attenzione per pochi temi ricorrenti, che ha raccontato catturandoci. Lettore appassionato, scrivendo per il teatro ha un’ossessione: dare una forma all’impossibilità di dire. Così, il limite incerto fra la verità e l’imbroglio, il gioco fra esitazione e rinuncia, la ricerca della parola esatta e la difficoltà di dirla sono i cardini del suo modo di raccontare. Ingigantisce le inezie e fa apparire lentamente il vuoto di una situazione, e così piccoli incidenti assumono proporzioni fuori controllo, le cui conseguenze decidono il fallimento di una esistenza o fanno emergere una delusione irrimediabile.
Jean-Luc Lagarce conosce davvero il teatro e i suoi tempi severi, e sa generare una tensione speciale che riaffiora da un testo all’altro imponendosi come stile. In scena il racconto ruota attorno a un unico personaggio, che lui contrappone o a un altro o a un gruppo riunito per qualche occasione stabilita – uno spettacolo, una festa di famiglia, una riunione di lavoro. Incontrandosi, parlano del teatro, del passato, di com’era prima, della famiglia o a volte del potere. Noi sappiamo che qualcosa sta per accadere, sta per essere detta. Aspettiamo. Ma non accade nulla, e per dire l’attesa Lagarce modula sospensioni, ripetizioni, frammentazione della frase, creando uno stile.
Questo libro è composto da una pièce, Music-hall, e da una raccolta di brevi saggi e appunti, Del lusso e dell’impotenza. Music-hall è una finestra socchiusa sulla vita del teatro: racconta le tournée di una attrice e dei due boys che la accompagnano. Nel loro girovagare incerto perdono pezzi, perdono sicurezze, perdono senso e identità, ma continuano ad andare in scena perché il teatro è per sempre. Più noi ci avviciniamo, più avvertiamo la loro paura. Di non esser ascoltati, di vivere nuovi abbandoni o di trovarsi improvvisamente di fronte a una scena vuota e di dover, comunque, recitare.
Music-hall è stato messo in scena per la prima volta in Italia nel 2012 in coproduzione con Rai Radio3, con la regia di Valentino Villa e con Daria De Florian, Marco Angelilli e Diego Ribon. È uno dei frutti del progetto Face à face, Parole di Francia per scene d’Italia, per il quale Valentino Villa ha messo in scena anche Noi, gli eroi di Lagarce con gli allievi dell’Accademia Silvio D’Amico. Prima di lui, nel 2009, Luca Ronconi aveva scelto nell’ampia rosa di autori presentati da Face à face due testi di Lagarce, I pretendenti e Giusto la fine del mondo e ne sono nate due creazioni al Piccolo Teatro di Milano. In quell’occasione, rileggendo insieme la traduzione dei Pretendenti, Ronconi con una immagine ha fissato la differenza fra il pubblico francese e quello italiano: “I francesi ascoltano, gli italiani guardano”.
Ma la prima occasione per scoprire Lagarce in Italia risale al 1997, poco dopo la sua morte, quando il Festival d’Autunno invitò Nous, les héros con la regia del suo caro amico Olivier Py, autore, attore, regista e oggi direttore del festival di Avignone.
Torniamo al libro: Del lusso e dell’impotenza è invece una raccolta di brevi saggi e articoli che prende il cuore. Sono stati scritti per presentare spettacoli e cartelloni, o sono appunti raccolti da Lagarce. Leggendoli liberamente ne vien fuori il ritratto di una creatura che conosce la passione per la bellezza, il lavoro in gruppo, la solitudine popolata di figure, l’ombra della morte e l’amore per la vita vissuta lealmente e a piene mani.
Eccone un estratto: “Una società, una città, una civiltà che rinuncia all’Arte, che se ne allontana, in nome della viltà, della pigrizia inconfessata, della ritirata in se stessi, che s’addormenta su di sé, che rinuncia al patrimonio di domani, al patrimonio in divenire per accontentarsi, nell’autosoddisfazione beata, dei valori che crede di aver forgiato e che invece ha soltanto ereditato, questa società rinuncia al rischio, si allontana dalla sua unica verità, dimentica in anticipo di costruirsi un futuro, rinuncia alla sua forza, alla sua parola, non dice più niente agli altri e a se stessa.
Una società, una città, una civiltà che rinuncia alla sua parte di imprevisto, al suo margine, ai suoi indugi, alle sue esitazioni, alla sua disinvoltura, che non rinuncia mai, nemmeno per un istante, a produrre senza riflettere, una società che non sorride più, nemmeno un poco, nonostante il dolore e lo sgomento, delle sue inquietudini e delle sue solitudini, una società così è una società che si accontenta di se stessa, che si abbandona completamente alla contemplazione morbosa e orgogliosa della propria immagine, alla contemplazione immobile della propria immagine menzognera. Essa nega i suoi errori, la sua bruttezza e i suoi fallimenti, se li nasconde, si crede bella e perfetta, mente a se stessa. Oramai avara e meschina, con la testa vuota, con i suoi risparmi di fantasia, sparisce e si inabissa, distrugge la parte dell’altro, che lo rifiuti o lo ammetta, si annega e si riduce al proprio ricordo, all’idea che s’è fatta di sé. È fiera e triste, nutrita della sua illusione, crede al suo fulgore, senza seguito e senza discendenza, senza storia futura e senza spirito. È magnifica, poiché lo dice lo crede e resta sola ad ascoltarlo. È morta”.
Pubblicare un testo di teatro è un’offerta: Hegel, nell’Estetica auspicava che i copioni venissero chiusi in cassaforte per preservarne il soffio, il respiro, la vita, per evitare che diventassero letterari. Ma i testi teatrali nascono nel respiro, si risvegliano appena lasciano la pagina e assumono subito un corpo un’andatura, un passo. Lagarce ha creato una lingua per dire l’indicibile e pubblicarlo è lanciare la sfida:
grazie quindi agli artisti che hanno fatto e faranno vivere ancora queste parole potenti. Senza le loro parole siamo ciechi.
Un grazie di cuore a Lorenzo Carlucci per i preziosi consigli durante la rilettura della traduzione.